Perché?
di Luisa Granata (IF, a.s. 2020-2021)
Notte fonda. Notte scura.
Di tanto in tanto m’intimorisce.
Barcollo per i vicoli stretti e umidi, tra cassonetti e gatti affamati, con la malinconia nelle tasche e mezza Winston.
La città mormora, borbotta insieme alle marmitte ferme e fumanti ai semafori annoiati, che sbadigliano colori alternati opalescenti.
Lampioni mezzi fulminati illuminano le strade, come stelle intermittenti nate per brillare.
Il ticchettio delle lancette coincide col sordo suono frettoloso dei miei passi sull’asfalto.
L’insegna al neon di un locale è riflessa in un piccolo e torbido lago di strada.
Il fumo della sigaretta si confonde con le nuvole incastonate nel cielo grigio.
L’immagine si deforma quando il mozzicone ci affoga dentro.
Qualcosa spezza la monotonia di questa sera.
Vengo attratta da un quadro rovinato, dimenticato, buttato nello stesso cassonetto dei sogni infranti e delle speranze bruciate.
La curiosità mi tiene in ostaggio.
Lo tiro fuori con attenzione, cercando di non danneggiarlo ulteriormente.
Lo tengo fermo, saldo.
Le mie dita ghermiscono la cornice deteriorata dal tempo.
La distanza tra me e l’immagine sembra come svanire, annullarsi.
L’attrazione tra noi è viscerale, il tempo è cristallizzato.
Il respiro si fa sottile, freddo, gelido, pungente.
Il battito rallenta, rimbomba nelle orecchie sovrastando qualsiasi altro suono.
La suspense tangibile viene infranta dall’allarme del maggiolino a qualche metro da me, fatto scattare da un gatto sbucato all’improvviso.
Vengo come stordita e, una volta ripresami, con il quadro messo meccanicamente sotto braccio, riprendo la via di casa.
Lascio cadere la borsa, con ancora i libri di medicina legale, che si accascia sul pavimento.
Getto le chiavi sul tavolo e dopo un ultimo sguardo al dipinto, lo poggio vicino al muro e vado a sedermi sul divano.
Con un bicchiere di vino purpureo in mano, sovrappensiero, fisso imperterrita il quadro.
Facendo roteare il vino nel calice, mi rendo conto che vi è raffigurato un volto avvolto da fiamme infernali.
È raccapricciante, cruento, vivido.
Sembra ardere davvero.
Una fiamma che aveva tutte le sfumature di un tramonto di settembre, trasmette dolore, strazio, quasi addirittura pazzia.
Più l’osservo, più acquisisce nitidezza, più brucia.
Nella mia testa, come una lontana eco, le urla dell’arso.
Cerco l’orario sul telefono, è tardi.
Lascio il bicchiere mezzo vuoto sul tavolo e giro il dipinto verso il muro. Spengo e luci, chiudo gli occhi. Giù il sipario.
Il sole filtra dalle tapparelle, qualche raggio mi solletica gli occhi.
Mi preparo per andare a lavoro.
Dopo aver preso tutto, vado verso la porta pronta per uscire, passando, però, prima dal salotto, dove vedo il quadro.
Lo giro e subito lo sconforto mi assale.
Resto pietrificata.
È cambiato.
Potrei giurarlo, è cambiato.
È spento.
Statico, immobile. Spento.
Intravedo il fumo rigare uno sfondo di pece.
Sul pavimento gocce di colore.
Incredibile. Terrificante.
Cerco di pulire senza chiedermi nulla, semplicemente non saprei darmi una risposta, una spiegazione valida.
Mi costringo a non ascoltare il vociare delle mille domande che mi ronzano nella testa.
Mi accorgo che la consistenza è densa, viscida, filamentosa.
L’odore ferroso, pungente, acre.
Sembrava… sangue.
Un brivido mi percorre la schiena, una conferma mi divampa nella testa e mi prende lo stomaco.
Lascio cadere lo straccio impregnato e istintivamente mi porto una mano sulla bocca, proprio sotto al naso, quasi per tapparmelo.
Disgustata e impaurita mi alzo di scatto ed esco di casa.
Arrivo all’obitorio e mi sento confortata dall’odore di morto, anche se pare un controsenso.
Il lavoro aiuta a distrarmi, mi permette di concentrarmi.
La porta si spalanca, sbattendo contro la parete, facendo entrare un nuovo sacco nero adagiato su di un carrello cigolante, spinto da un uomo sulla sessantina, che a malapena il camice riusciva a contenerlo.
Eric Smith: l’uomo più banale del mondo.
La classica persona adirata col mondo per i suoi insuccessi e fallimenti vari, abbandonato dalla moglie per il personal trainer di pilates e devastato dalla psoriasi.
In ogni caso, un volto rassicurante, familiare quanto meno.
Indosso i guanti come una seconda pelle, faccio scorrere il cursore della cerniera per scoprire chi si celasse all’interno.
Un déjà-vu.
Resto ferma, sembro calma. Il sangue mi si gela nelle vene.
Il professore legge la scheda del soggetto.
La sua voce fa rumore, le parole non sembrano tali, sono ovattate, storpiate, sovrastate da un forte e duraturo fischio.
Ritorno in me e capisco perché il volto carbonizzato di questo corpo ormai privo di forma e indegno dell’appellativo di persona mi sia così familiare.
Sgrano gli occhi. La mascella s’irrigidisce, i denti si digrignano.
È lui! È l’uomo del quadro.
È impossibile. È surreale. Eppure è qui davanti a me, sulla fredda barella d’acciaio.
Immobile, stavolta. Muto. Morto.
Prendo in mano la sua scheda, leggo la sua vita nero su bianco e realizzo che fosse una persona prima di diventare carbone bruciato. ”La polizia ha ritrovato il corpo in una stalla” – esordisce con tono monotono il professore – “le cause non si conoscono, ma il decesso è avvenuto altrove. Immagino già i titoli della stampa: “Roasted meat”.
Il povero cristo si chiamava Meat, Jonathan.
Il professore amava il suo umorismo cinico, sarcastico.
Anch’io l’amavo, era unica cosa attraente – per così dire – presente in lui.
Come da prassi, annoto ciò che dice il professore: “Il soggetto è morto per combustione: non risulta alcun tipo di ferita sul corpo.”
“Avrà sofferto…” – lo interrompo io.
Uno scomodo silenzio mi costringe ad accennare un sorriso tirato, mentre cerco con lo sguardo il volto del professore.
Mi aspettavo una risposta immediata, seria.
I suoi pensieri gli rimbombavano nella testa, ne sentivo il trambusto. Nei suoi occhi una luce strana, scintille.
Tra la barba incolta, brizzolata e le rughe, un sorriso si curva lento.
Intravedo i denti ingialliti da vizi e cattive abitudini.
Non è felice.
In qualche modo, però, sembra compiaciuto, concentrato. Mi fa quasi paura. Tutto ciò dura un minuto e poco più.
Il tempo necessario per intimorirmi.
Certe volte il tempo si dilania, sviscerato dalla cura che la mente impiega nel cogliere i dettagli.
“Professore?” – dico con voce ferma.
Sbatte un paio di volte le palpebre e mi sorride, come se si svegliasse.
“Avrà sofferto, non crede?” – gli ripeto fredda.
“Si certo… povero” – mi dice.
“Non mi avrà sentito la prima volta” – penso, rassicurandomi.
Torno a scrivere finché le parole non si consumano prima dell’inchiostro.
Palazzi alti fanno da contrasto ad un tramonto fior di pesco.
La giornata sta finendo.
Dopo aver salutato colleghi vivi e morti, uscendo, chiudo la porta.
I soliti posti, la solita strada, finestre come quadri vuoti.
Le solite insegne, il solito gatto, i cassonetti, i lampioni, il quadro.
Faccio ancora qualche passo prima di realizzare. Mi fermo.
Riavvolgo la pellicola e, sperando di aver visto male, torno indietro.
Troppe cose mi fanno paura.
Troppe cose mi sembrano surreali.
Sembra di vivere in un sogno.
Peggio, in un incubo.
Incuriosita, raccolgo il quadro.
Cerco di rimanere distaccata. I gomiti formano un angolo acuto.
Un albero, un paesaggio e nulla più.
Per la precisione, un salice piangente sullo sfondo, un cielo ancora più triste di lui.
Una spenta primavera ormai agli sgoccioli.
Tetro, grigio, pastello.
È angosciante, ansiogeno.
Mi trasmette qualcosa che ho già provato. Non so cosa.
Nel dubbio, lo porto a casa.
Lo appoggio al muro, affianco all’altro dipinto.
Cerco qualche ulteriore legame tra i due.
Dovrà pur significare qualcosa il ritrovamento nel medesimo nonché insolito luogo.
Lo fisso assorbita, concentrata.
Le palpebre si fanno pesanti, iniziano a chiudersi.
Le riapro prontamente.
Poi, però, accade di nuovo.
Cerco di rimanere sveglia per trovare qualche connessione tra i due quadri, osservo attentamente.
Un salice, nulla più.
Tutto fermo. Nella più scontata normalità, la vista si offusca.
Le linee si sdoppiano, le immagini si opacizzano, lo sfondo si sfoca.
Tutto si scurisce. Buio.
Mi abbandono alle amorevoli braccia di Morfeo.
Mi accorgo d’essermi assopita.
Di soprassalto, mi sveglio.
Uno sguardo di sfuggita al quadro, è ancora lì.
L’orologio segna le tre e trentadue. Tardi.
Decido, però, di tornare ad osservare quel maledetto quadro.
Ecco, ci siamo… Che tempismo inquietante.
Sembra muoversi qualcosa.
Non è la stanchezza a giocare brutti scherzi, non sono allucinazioni.
I pioppi sullo sfondo oscillano.
Le nuvole affollano il cielo.
Le foglie ballano al vento che sembra ululare continuo.
Raffiche rapiscono queste ultime ed il vento aumenta, strilla capriccioso, isterico.
Lancio un’occhiata alla finestra, scrutando il cielo nero, che è limpido, terso, calmo.
È il quadro, è come se fosse una finestra sull’altra parte del mondo.
Inquietante. Interessante.
Sono allibita, ma curiosa, sull’orlo di un collasso, di una crisi di nervi.
D’ un tratto i rami del salice prendono vita.
Lacrime lucenti scorrono lungo di essi.
Come tende di un palcoscenico, si separano lenti: si va in scena.
Svelano un tronco grigio topo, fin ora celato.
È storto, torto, tortuoso.
Solchi profondi sembrano rughe più che venature.
Riesco a definirlo, a delinearlo.
Risaltano i particolari, assume sembianze umane, si contorce dal dolore, il tronco.
Sento le urla, le grida.
La tortura subita è straziante, orripilante. Macabra.
Percepisco le ossa scricchiolare, frantumarsi con altre.
Rabbrividisco.
Sul volto antropomorfizzato agonia, supplizio, dolore atroce che lacera, dilacera la corteccia decadente.
Pezzi di questa si staccano, cadono sul suolo intrisi di sofferenza.
S’intravede la carne, i fasci muscolari.
Rosso vivido, polposi.
Non resisto.
Distolgo la vista accasciandomi.
Cado sul pavimento freddo, la mia pelle sembra di vetro.
Le grida mi si strozzano in gola, come stretta da una mano che m’ impedisce quasi di respirare.
Inizio a piangere, restituendo ai quadri tutto l’orrore.
Domando loro il motivo per il quale le mie giornate siano diventate un film dell’orrore e perché io ne sia l’unica spettatrice.
Non riesco a smettere di piangere, singhiozzo.
Mi bruciano gli occhi, sulle guance, solchi neri.
Non riesco a vedere più nulla, non distinguo ciò che ho attorno.
I miei pensieri razzolano nella stanza.
Tutto è confuso, mischiato.
Sento ancora il vento del dipinto sbuffarmi in faccia.
Le foglie cadono sul pavimento, alcune le ho impigliate nei capelli.
Le urla dell’uomo rimbombano nelle orecchie, sovrastando il suono del vento.
Vorrei tutto si fermasse.
Sono stanca, satura.
Riesco ad urlare: “Basta!”
Occhi rossi e nervi a pezzi.
Silenzio.
Mi dondolo con le ginocchia al petto, cercando di rassicurarmi, di rincuorarmi, come una bambina.
Non riesco a tenere gli occhi aperti, mi bruciano.
Appassisco pian piano.
Il vento si placa, l’uomo esala l’ultimo gemito.
Il cielo si schiarisce, spazzando via la notte, le stelle e gli incubi.
Gli uccellini cinguettano, cantando i sogni dei bambini al sole sorgente.
Il calore dei raggi riscaldava la mia pelle.
Trovo la forza per alzarmi.
Calpesto le foglie secche sul pavimento e le sento sbriciolarsi.
Mi guardo allo specchio, osservo il mio riflesso.
È distrutto, sfiancato, frammentato.
Mi lavo il viso.
Goccioloni neri sporcano il lavandino candido.
Trucco e tenebre scivolano nello scarico.
Mi cambio, mi preparo ed esco di casa senza guardare il quadro.
Seguo i miei passi fino all’obitorio.
Mi sento sicura lì, protetta.
Come da prassi, faccio le cose meccanicamente, senza pensarci.
Indosso il camice, i guanti, gli occhiali, lego i capelli.
Avverto un cigolio avvicinarsi e conto diciassette secondi, il tempo che impiegava il carrello a percorrere il corridoio.
La porta si spalanca in perfetto tempismo.
Definirei questa monotonia inquietante, se solo non avessi conosciuto davvero il significato di questa parola.
Penna e quaderno in mano.
“Silenziosa oggi, eh?” – mi dice il professore.
Una mia occhiata e le sottostanti occhiaie gli suggeriscono che oggi non è il caso di scherzare.
La lampo arriva ai piedi del sacco.
Non guardo nemmeno chi c’è dentro, inizio a compilare la scheda basandomi sulle parole del professore: “Maschio, intorno ai venticinque–trent’anni, un metro e ottanta circa, tra i settanta e gli ottanta chili. Presenta segni di corda attorno ai piedi. Vaste aree scuoiate. Ben visibili le fasce muscolari nella zona lombare, sul pettorale grande sinistro, deltoide, trapezio e massetere.
Nella zona del grande dorsale, un lembo di carne adeso per quattro centimetri e mezzo.”
Incuriosita, guardo il corpo e mi prende lo stomaco.
Mollo tutto e corro verso il lavabo.
Un conato di vomito mi riga la gola.
Cerco di ingoiare, ma butto tutto fuori.
Lacrimano anche gli occhi.
Le braccia sono tese, il palmo stringe l’acciaio e la testa cade in avanti, stretta tra le spalle.
Mi riprendo, pulisco e torno alla lettiga.
Quel volto straziato, tormentato, non potevo non riconoscerlo.
Il protagonista del quadro, anche stavolta era lui.
Comprendo, dunque, che i dipinti siano presagi, annunciatori di morte.
Continuavo, però, a non trovare un filo conduttore tra loro e me.
Perché io? Perché?
Il professore mi guarda dubbioso – “Non ti facevo così suggestionabile.”
“Ho soltanto avuto una nottataccia”
Esaminiamo il corpo e compliamo le schede.
Era stato ritrovato appeso per i piedi ai ganci del mattatoio a due isolati da qui, come un vitello.
Una scena raccapricciante.
“Due omicidi in così breve tempo. Un serial killer? Possibile? Quante poche certezze, sembra di stare in un film…” – esordisco non accorgendomi di star pensando ad alta voce.
Scuoto la testa più volte.
Il professore mi si avvicina da dietro, cingendo con una lenta carezza i miei fianchi.
Le sue mani grosse, tozze, mi fanno tremare il cuore.
Sento il palmo e quattro dita ruvide appendersi al camice, emanare calore, solleticare quasi la mia pelle.
Brividi lungo la schiena.
Cerco di giustificare la sua malizia con un frainteso gesto di conforto.
Mi volto piano.
Vado dall’altra parte del carrello per creare una barriera, senza dare nell’occhio però.
Fingo di sistemare qualcosa.
“Vado a prendere un caffè, gradisci qualcosa, cara?”
Sorrido e rifiuto.
Resto sola nella stanza con il cadavere.
Prima di chiuderlo nella cella frigorifera, lo guardo, come un genitore il proprio figlio quando dorme.
“Ti ho visto, sai? Ero lì con te.
Ho visto il dolore asfaltare il tuo volto. Ho sentito le urla graffiarti la gola e l’anima. Chi ti ha ridotto così? Che è successo al povero – cerco il nome sul cartellino con i dati personali e, oltre a leggere il nome, guardo la foto della patente – Anthony O’brian.”
No, non può essere lui.
Come neve candida, il cuore cade silenzioso in un baratro freddo, scuro, profondo.
Sgrano gli occhi e faccio un passo indietro.
Con voce tremolante e incredula – “Anthony, amico mio, non puoi essere tu, no, non puoi…”
Perdere un amico è devastante.
Lo è ancor di più vederlo morto, con sembianze umane ma non quelle di persona, fermo su di una lastra d’acciaio con qualche riflesso delle lampade al neon situate sopra di questa.
Sono passati anni dall’ultima volta.
Eravamo ad un bar, lo ricordo bene, tu prendesti uno Spritz.
Eri felice, sorridevi quanto meno.
Avrei voluto ricordarti così.
E, invece, sei qui, freddo, morto.
Non riconosco nemmeno il tuo sorriso, così raggiante, splendente, contagioso.
Eppure quello ce l’ho ancora bene impresso.
Mi suona in testa la tua risata, come fossi nella stanza accanto.
E lo sai, mi sembra ieri l’altro.
Non permetto alle mie emozioni di modificare il mio volto imperterrito.
Lobotomizzata, plasmo solo una sfera, una bolla di sapone gonfiata dall’incredulità, rimpianti e lacrime asciutte.
Vorrei abbracciarti.
Non posso, non riesco.
Quel corpo non sei tu.
Mi chiedo poi se identifichiamo noi stessi con il nostro corpo o con la nostra anima.
Spingo la lastra verso il gelido riposo, col cuore gonfio, come stritolato da una morsa.
Con un sospiro scatta la maniglia.
Ti saluto accarezzando il portellone. Tolgo il camice, prendo la borsa e vado verso il bar.
Chiedo al professore di potermi congedare.
Mi saluta con un’espressione grottesca e gli occhi serrati.
A passo svelto percorro la solita strada.
Mi blocco. Un altro quadro sempre allo stesso posto.
Un macabro rituale.
Decisa, disperata, stizzita, quasi adirata lo raccolgo e lo porto a casa.
Non so bene, però, il perché di questa mia scelta.
Evidentemente la confusione dettata dal contrasto di mille idee aveva sovrastato totalmente il buon senso, la ragione.
“Vediamo adesso cos’hai da dirmi!” – gli urlo contro dopo averlo messo vicino agli altri due.
Come un bambino davanti ad un teatrino delle marionette, a gambe incrociate, in attesa dello spettacolo, impaziente, mi siedo guardando i tre scenari funerei.
Il telefono squilla.
Che squillasse pure! Ora devo capire.
Non ho tempo per la realtà.
Fisso la tela sporca di colori stanchi.
Un ponte di mattoni rossastri eretto su un fiume azzurro triste.
Tutto sembra sbiadito. Non c’è vita.
Anche la natura pare morire.
Afferro il bicchiere di vino rosso di qualche sera fa.
In preda al nervosismo, lo scaglio violentemente contro il quadro, come per ferirlo.
Il bicchiere si frantuma, schegge di vetro sul tappeto.
Come un quadro di Fontana, la tela si lacera, si sfregia, si squarta.
Gocce di vino macchiano il cielo che pare piangere sangue.
Il liquido color rubino gocciola e, insieme a questo, l’acqua del torrente straripa dalla cornice.
Dondola lenta una gondola nera, che appare all’orizzonte, materializzandosi dalla foschia verdastra.
L’acqua aumenta.
Resto ferma.
La tocco, per capire se sia reale: è fredda, gelida.
Aspetto che la barca si avvicini, attendo curiosa, ansiosa.
Sento piangere.
Pezzi di vetro galleggiano sull’acqua dolce.
Passa sotto al ponte.
Più si avvicina, più è nitida.
Due persone vi sono a bordo: il gondoliere ed una dama bianca d’altri tempi.
L’uomo smette di vogare. Si asciuga la fronte e, assecondando il movimento del braccio, si volta cercando il mio sguardo.
I suoi occhi, come coltelli, fendono la mia pupilla.
Un ghigno gli si modella sul viso, sollevando le gote paffute, coperte da un’incolta barbetta brizzolata.
Un raggio di sole si riflette sugli occhiali tondi e scintillanti.
Sgrano gli occhi, mi ghiaccio.
Il labbro m’inizia a tremare.
“No… No.” – dico con due sospiri pieni di sconforto.
Continuo ad osservare pietrificata il quadro come se fosse un film.
È il professore il gondoliere.
La dama svela il suo delicato viso, celato sin ora da un ombrellino bianco pizzo.
Non ho tempo per osservarlo, devo avvisare il professore: è in grave pericolo.
Mi alzo con uno scatto e vado verso la porta.
Calpesto correndo i pezzi di vetro non del tutto infranti, l’acqua schizza ovunque.
È una corsa contro il tempo, spero.
Forse posso ancora impedire che accada.
Non mi importa di nulla.
Attraverso i semafori rossi, non saluto nessuno.
Sono preoccupata.
Chiedo al barista dove sia il professore e lui mi indica l’ascensore.
Mi precipito verso di questo.
Ho il cuore che rimbomba nel petto come amplificato.
L’ascensore è lento.
Devo aspettare, ma non ho il tempo ne’ la pazienza per farlo.
Prendo le scale.
Quasi cado nella foga della fretta. Mi tengo al corrimano per evitarlo.
Stringo le curve.
Sento addirittura il rumore dei miei passi precedermi.
Sfondo la porta.
“Professore! Professore stia attento, è in pericolo, qualcuno sta per… – Affannata, apro gli occhi, mi rendo conto di essere l’unica anima viva nella stanza – ucciderla.” – concludo.
Mi calmo e vado a sedermi sullo sgabello d’acciaio.
Mi massaggio la testa e poi mi sistemo i capelli.
Ripenso al quadro.
Cerco di ricordarlo per avere qualche indizio utile, quanto meno ulteriore.
Completa, l’immagine del quadro ritorna ai miei occhi.
È come una fotografia.
Riesco a visualizzare e a mettere a fuoco ogni dettaglio, ogni parte del dipinto, è affisso nella mia mente.
Il gondoliere continua a sorridere, come se stesse in posa.
La mia attenzione si sposta sulla dama bianca che ho trascurato in un primo momento.
È graziosa, bella e triste come Venezia.
Cerulea, con le gote imbarazzate da qualche complimento.
L’immagine non si ferma, continua come una storia.
L’acqua fuoriesce dai tagli della tela.
I miei pensieri annegano.
Man mano che la gondola avanza, l’esile collo della dama candida combacia con il taglio della tela.
Sangue si mischia col vino. Riga il quadro come pioggia sui vetri.
Riesco a vedere bene i suoi occhi: verdi, disperati, terrorizzati.
Sul viso, un’espressione di stupore, paura.
Adesso il quadro mi è ben chiaro.
Una folgore m’illumina.
Sento un vuoto nello stomaco.
I piedi formicolano, così le dita delle mani.
La testa è leggera.
Il cuore sembra aver subito una scarica elettrica.
Il pavimento si sgretola sotto ai piedi.
Sento come un mancamento.
Ho paura, la dama sono io.
Poggio un piede a terra e volto il busto.
Freddo improvviso sulla mia gola, poi calore.
Un taglio netto.
Istintivamente, porto una mano alla gola.
Sento il sangue che scorre, la vita che mi scappa dalle dita.
Pietrificata in volto, cerco aria, ma trovo solo sangue che mi impedisce di respirare.
Annaspo strozzandomi.
Ho solo il tempo di vedere gli occhi del mio assassino.
La mia espressione muta in fretta.
Sono stupita, perplessa, incredula.
Ferita nell’anima oltre che sgozzata.
Il professore davanti a me. Un coltello insanguinato.
Il mio sangue.
Che gocciola.
Schizzi sul suo camice, ovunque.
Vorrei gridare, piangere, pensare.
Soffocata da me stessa, tutto mi è impossibile.
L’unica cosa che riesco a dire, mimandola con la bocca e con un filo di voce è: “Perché?”


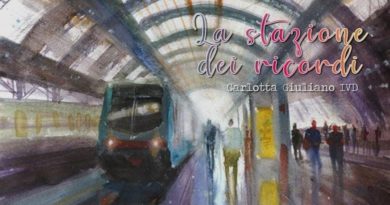

Non amo questo genere di letture, ma devo dire che quando ho iniziato a leggere questo testo non mi sono potuta fermare finché non sono arrivata all’ultima parola, tanto mi ha preso!!!…. Complimenti all’autrice. Continua così!
grazie mille🥰
Brava!
Continua a prenderti cura del tuo dono, perché è davvero prezioso.
Wow
Letto tutto d’un fiato.
Avvincente e pieno di ritmo, degno di un noir di grandi autori.
Particolareggiate le descrizioni dei luoghi e delle emozioni.
Continua così! E chi lo sa, un giorno leggeremo un bellissimo romanzo.