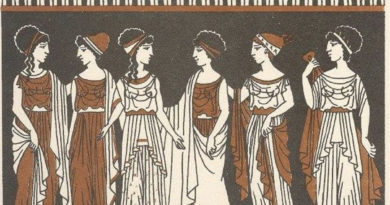Un altro Edipo- Robert Wilson legge l’Oedipus Rex
della Prof.ssa Maria Palumbo
È in scena al teatro Mercadante Oedipus Rex di Sofocle in una trasposizione decisamente innovativa del
regista statunitense Robert Wilson. Wilson, che si è dedicato anche alla scultura ed alla pittura, oltre che
alla coreografia, vanta una collaborazione artistica con scrittori del calibro di Allen Ginsberg e William
Burroughs. Nel 1968, Wilson fonda la compagnia di performance sperimentale Byrd Hoffman School of
Byrds, dedicata a Miss Hoffman, l’insegnante di danza che lo aveva aiutato a vincere la balbuzie che lo
affliggeva da ragazzo, abituandolo ad eseguire movimenti lenti (slow motion): tale pratica risulterà una
delle caratteristiche essenziali del suo teatro. Nel 1993 vince il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia per
una installazione scultorea. Nel 1997 ottiene il Premio Europa per il teatro. La sua opera più celebre è I
La Galigo, realizzata nel 2004 e basata sul poema mitologico indonesiano Sureq Galigo. Lo spettacolo
consta di una serie di quadri interpretati da cinquanta performers indonesiani tra musicisti, cantanti e
attori/acrobati/danzatori e si serve di effetti di luce molto particolari e straordinari giochi di colori.
Questo tipo di linguaggio scenico si ritrova anche nella rilettura dell’Edipo Re di Sofocle, già presentato a
Vicenza ed al Teatro Grande di Pompei. Wilson smonta in modo dissacrante il testo, dissolvendo
completamente l’intreccio narrativo, che si suppone essere noto allo spettatore. Lo spettacolo si compone
di una serie di quadri che sembrano avere una propria unità narrativa e che si servono di un uso sapiente
del gioco di luci ed ombre, dei colori e dei suoni. La storia di Edipo è rappresentata come l’archetipo
universale dell’eterna lotta tra l’uomo ed il destino, che parla ad ognuno di noi oltre i confini dello spazio
e del tempo, per questo i pochi brani recitati vengono ripetuti lentamente ed ossessivamente in cinque
lingue: greco, italiano, inglese, francese, tedesco. Anche i costumi evitano volutamente ogni riferimento
ad un contesto storico ben preciso. Si passa da corpi fasciati e quasi scolpiti a figure pietrificate ed
intrappolate in strutture rigide ed informi simili a grotteschi idoli di pietra.
L’elemento determinante dell’intero spettacolo è costituito dalla luce: Edipo è alla ricerca della verità,
vuole scoprire chi ha contaminato Tebe provocando la pestilenza, ma non sa di essere sulle tracce di se
stesso. La scena di apertura è costruita in questo modo: una figura immersa nell’ombra si muove
lentamente nella direzione di un riquadro luminoso dominato da una sfera di luce; è il viaggio di Edipo
alla scoperta di se stesso, nel cammino inesorabile che lo condurrà fuori dalle tenebre e lo porterà ad
accecarsi per aver visto troppo.
L’intero spettacolo è volutamente caratterizzato dal gioco di luci ed ombre. I personaggi-chiave sono
individuati da un fascio luminoso, lasciando volutamente il resto della scena nell’ombra. Quando Edipo si
insedia sul trono di Tebe, egli crede di aver raggiunto l’apice della sua realizzazione personale ma, in
realtà, è del tutto inconsapevole di ciò che il destino ha deciso per lui, quel destino a cui non si può
sfuggire.
La sua cecità è rappresentata da un involucro che gli ricopre completamente la testa come un bozzolo,
mentre lui, prepotentemente, brandisce ed ostenta un ramo d’oro, simbolo del potere regale. La scena del
disvelamento della verità è narrata sulla scena con una lunga sequenza in cui gli attori, immersi
nell’oscurità e con lentissime movenze, simili ad automi, sistemano con ordine quasi maniacale delle
sedie. Ma il bisogno di ordine proprio della natura umana, incapace di gestire e sopportare il caos
dell’esistenza, è improvvisamente scompaginato dall’irruzione del protagonista che, accompagnato da
suoni stridenti, scaraventa a terra le sedie mentre una luce violenta illumina la scena. È la luce della
verità, che Edipo non riesce a sopportare, che scompagina il finto ordine, la finta rassicurante razionalità a
cui ci aggrappiamo per provare a difenderci dal caos.
Ai mortali non è dato conoscere il futuro, così l’intera esistenza si svolge nella totale inconsapevolezza di
noi stessi, fragile ed effimera. La scena in assoluto più bella è, a mio parere, quella in cui Edipo ripete in
maniera ossessiva a Zeus la domanda: “perché?”. Ci sono tre figure maschili che scandiscono la
ripetizione dei versi con suoni cupi provocati da lamine di metallo su cui battono ritmicamente i piedi,
mentre il tutto è immerso in un chiaroscuro dai toni azzurri, che crea un’atmosfera irreale ed atemporale.
L’esperienza artistica di Wilson è sicuramente provocatoria. Un pubblico che si aspettasse l’adesione
ortodossa al testo classico resterebbe senz’altro deluso, infatti gli applausi che hanno accompagnato la
fine dello spettacolo sono stati indiscutibilmente piuttosto tiepidi. All’uscita i più commentavano di non
aver capito nulla.
Smontare un testo letterario è, tuttavia, un’operazione assolutamente legittima, nella misura in cui un
artista, nel consegnare il proprio prodotto ai posteri, sa bene che questo sarà suscettibile di ulteriori
interpretazioni. I puristi fautori dell’adesione incondizionata al testo troveranno senz’altro discutibile un
distacco così radicale dal prodotto iniziale, ma se un’opera classica può parlare ancora oggi ad un vasto
pubblico, la sua universalità consiste proprio nell’aver saputo toccare degli archetipi dell’immaginario la
cui attualità va ben oltre le barriere dello spazio e del tempo.
È questo l’ardito esperimento messo in campo da Wilson, che utilizza il testo di Sofocle come un
canovaccio da scomporre e ricomporre a proprio piacimento. Un limite da imputare ad un esperimento del
genere può essere individuato, a mio parere, nell’eccesso di intellettualismo. Ogni scena, ogni oggetto,
ogni suono, ogni immagine sono il precipitato di una sapiente, colta e raffinata rivisitazione del soggetto
originale, che tuttavia poco si cura della sua fruibilità. Ciò comporta la scarsa o nulla leggibilità del testo
teatrale da parte di un vasto pubblico scarsamente abituato alla sperimentazione o privo dei necessari
strumenti. Se fosse davvero così necessario costruire un prodotto teatrale di difficile fruizione è forse
opinabile; resta tuttavia la genialità dell’aver saputo rileggere un mostro sacro della letteratura di tutti i
tempi, servendosi di codici comunicativi alternativi alla parola e di grande impatto emotivo, come la luce,
i gesti, i suoni.
In merito alla necessità avvertita dai più di un’adesione rigorosa al testo classico, vorrei ricordare le acute
osservazioni del filosofo contemporaneo Hans Georg Gadamer. Nell’occuparsi dell’ermeneutica
dell’opera d’arte, Gadamer sottolinea come tra l’autore ed il fruitore intercorra un dialogo inesauribile che
rompe le barriere dello spazio e del tempo. Chi compone un’opera d’arte sa bene che essa è destinata ad
entrare in rotta di collisione con gli orizzonti di senso dei suoi interpreti e dei suoi fruitori. Non ha alcun
valore, pertanto, chiedersi se un direttore d’orchestra ha ben interpretato le intenzioni del compositore,
perché quest’ultimo, nel momento in cui ha consegnato ai posteri la sua creazione, l’ha fatto proprio
affinché essa venisse interpretata. Si ha arte nel momento in cui si incontrano gli orizzonti di senso
dell’artista e del suo interprete, che a loro volta si sovrappongono all’esperienza estetica del fruitore in
una dimensione radicalmente polisemica. Se dunque Sofocle ci ha consegnato un testo che parla ancora
oggi alle nostre coscienze, alla sensibilità di ognuno di noi, è assolutamente legittimo rivederlo,
reinterpretarlo, manipolarlo.
“L’arte richiede interpretazione poiché è caratterizzata da una ambiguità inesauribile (…). La plurivocità
della poesia è inscindibilmente connessa con l’univocità della parola significante. (…). Questo perdersi
nell’interpretazione dell’ambiguo appartiene all’essere stesso dell’uomo. Questa ambiguità è propria
anche della parola del poeta (…). Ciò che la poesia interpreta e ciò che la poesia indica non è
naturalmente ciò che intende il poeta. (…) L’essenza [dell’arte] consiste nel rinviare ad altro da sé
lasciando scorgere ciò di cui il poeta parla. Né l’interprete né il poeta possiedono il potere di
autolegittimarsi, perché entrambi sono già sempre trascesi da ciò che accade in modo autentico nella
poesia. Entrambi seguono un cenno che indica verso l’aperto.” (GADAMER, Hans Georg, L’Attualità del
Bello, Genova, Marietti, 1986, pp. 85-86).