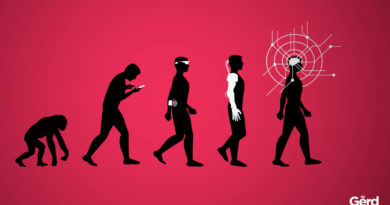La malinconia della e nella letteratura: da Virgilio a Buzzati
di Ginevra Fracasso (IIA)
La malinconia è una sensazione tanto sfumata quanto intensa che si interpone fra l’uomo e il mondo esterno e che porta all’assiduo indugiare nel proprio universo interiore, a sfiorare le ferite che il passato ha causato, a carezzare quel velato dolore sino a contemplarne la sottile e nascosta meraviglia di fondo. La malinconia attanaglia lo spirito degli uomini che guardano al passato con un senso di pesantezza il quale, tuttavia, sembra essere una lieve carezza prospettiva di pace e dimora sicura.
Tale valore ossimorico risulta manifesto nella definizione “la gioia di essere tristi”, data dall’illustre scrittore, poeta e drammaturgo francese del XIX secolo Victor Hugo, il quale riuscì pienamente a cogliere la complessa essenza di un sentimento a tal punto sfaccettato quale la malinconia.
Dal punto di vista etimologico, “malinconia” deriva dal latino “melancholia”, che a sua volta trae origine dal greco “melancholía”, composto di “mélas, mélanos” (nero), e “cholé” (bile), quindi “bile nera”, uno dei quattro umori dalle cui combinazioni dipendono, secondo la medicina greca e romana, il carattere e gli stati d’animo delle persone.
Fortemente legata alla malinconia è la nostalgia, dal greco “nostos” (ritorno) e “algos” (dolore), dunque “dolore del ritorno”, che dà un nome a quel sentimento di mancanza verso un luogo o una persona.
Malinconia e nostalgia sono allora gli “effetti collaterali” che rendono succubi i molti che si sono voltati a guardare la strada della propria vita ormai offuscata dall’ombra del presente, e costituiscono uno dei caratteri più affascinanti e misteriosi della natura umana, a tal punto da divenire pilastri della letteratura di tutti i tempi.
Sono assai numerose le figure di rilievo che hanno provato a dare una forma e un motivo alla malinconia, la quale diviene una costante irremovibile, assidua, nella vita dell’uomo.
“Perché”, si chiedeva Aristotele, “gli uomini che si sono distinti nella filosofia, nella vita pubblica, nella poesia e nelle arti sono melanconici, e alcuni al punto da soffrire dei morbi che vengono dalla bile nera?”.
Aristotele, stilò una lista dei più grandi eroi e intellettuali accomunati da quel retrogusto malinconico tanto enigmatico. Nell’elenco, tra le numerose figure, emergono certamente Ercole, Bellerofonte, Eraclito e Democrito.
Giorgio Agamben, filosofo italiano contemporaneo, ha arricchito ulteriormente tale lista aristotelica, vedendo la malinconia quasi come una vera e propria epidemia, la quale si espande velocemente nelle epoche che, dal punto di vista culturale, più ne favoriscono lo sviluppo collettivo.
In primo luogo, l’essenza di malinconia velata si scorge sin dall’età augustea nelle “Bucoliche” di Virgilio, nelle quali i paesaggi pastorali e stilizzati si configurano come un locus amoenus che oggi definiremmo idillico. Infatti, se in antichità il termine “idillio” indicava un generico “bozzetto”, col tempo ha assunto un significato differente, un “quadretto georgico o pastorale” dalle note malinconiche e serene che, ancor prima di Virgilio, aveva costituito una parte importante degli “Idilli” di Teocrito, poeta greco siracusano vissuto nel III secolo a. C.
Già, allora, ai tempi dapprima di Teocrito e poi di Virgilio (I secolo a. C.), nella letteratura emergeva un sottotono malinconico e nostalgico a dir poco affascinante.
Tale sfumatura velata ha caratterizzato anche la Commedia dantesca, e, più nello specifico, il Purgatorio, cantica molto vicina all’uomo e alle sue debolezze e fragilità.
Francesco De Sanctis, critico letterario, saggista e politico italiano tra i più influenti del XIX secolo, ha tratteggiato la sostanza del purgatorio innanzitutto attraverso la definizione di quest’ultimo come “processo di carne e spirito”, vale a dire margine sottile e sospeso, in bilico tra la forma e l’essenza.
Il purgatorio si configura come luogo di passaggio nel quale la carne diviene, secondo De Sanctis, “pittura, estasi, sogno, simbolo” e contenitore della nuova e più profonda verità, quella divina.
Dante, nel purgatorio, incontra anime affettuose e temperate, emblematiche della condizione di graduale elevazione spirituale che accomuna ogni ombra destinata all’approdo in paradiso. Ne è valido esempio l’incontro con lo spirito di Stazio, autore classico molto noto tra il XIII e il XIV secolo; egli aveva composto la “Tebaide”, poema epico che si riallacciava al ciclo tebano, incentrato sulla lotta tra Eteocle e Polinice.
Stazio, quindi, corre incontro a Virgilio per abbracciarlo, proprio come farà Casella con Dante.
“Oh ombre vane, fuor che nell’aspetto!
tre volte dietro a lei le mani avvinsi,
e tante mi tornai con esse al petto”.
Dunque, ha continuato De Sanctis, tale mondo così affettuoso è pregno di malinconia ricolma di delicata tenerezza che ritrova piena essenza in quelle immagini rese profonde e intime dalle sfumature di dolce dolore.
L’illustre critico ha altrettanto ritrovato quella vena malinconica e desolata nel Petrarca e nei suoi sonetti contraddistinti da una grazia esemplare, con la quale il poeta ha rievocato il dolore condensato nel proprio spirito e l’ha alleviato e sciolto in parole di una bellezza unica e priva di qualsiasi rancore pungente.
La grazia è espressa, nel Petrarca, attraverso la fantasia, la quale differisce dal sogno, poiché, se quest’ultimo sopprime le condizioni di spazio e di tempo, quella, scrive De Sanctis, “dà agli oggetti tutta l’apparenza della più precisa realtà”.
Tale immaginazione è destinata però a esaurirsi e a lasciare nuovamente spazio alla fredda verità, nella quale l’ebbrezza dell’illusione si scontra inevitabilmente con l’amarezza del mondo esterno.
Se da un lato questo doloroso ritorno al concreto ha portato il poeta a soffrire, d’altra parte tale sofferenza non è risultata essere tanto intensa da impedire a Petrarca di calare ancora una volta la propria mente in un impetuoso flusso di fantasie avvolgenti e rassicuranti. Nasce così una malinconia penetrante e delicata al contempo, uno stato dell’animo misto e complesso, indeciso tra il dolce e l’amaro, nel quale sentimenti contraddittori si fondono indissolubilmente dando origine a sfumature del sentire complesse e misteriose.
D’altronde, fu proprio Immanuel Kant, filosofo tedesco vissuto tra il XVIII e l’XIX secolo, a definire la malinconia come una condizione talmente sfaccettata da apparire a tratti terribile: mentre gli altri uomini sono destinati a vivere in un assiduo equilibrio di emozioni, colui che è malinconico si trova, in ogni istante della sua esistenza, in balia dell’oscillazione e della contraddizione talvolta lacerante dell’estenuante eccesso di dolore e tenebre, le quali sono inspiegabilmente avvolte dalla luce di una profonda e spirituale gioia del cuore.
La malinconia diventa dunque molto più di un momentaneo sentire dell’uomo: diviene una costante dell’anima, la maggior parte delle volte inspiegabile, apparentemente insensata. Proprio su questo aspetto il filosofo ottocentesco Sören Kierkegaard si espresse con la frase: “se si domanda a un malinconico quale ragione egli abbia per esser così, cosa gli pesa, egli risponderà che non lo sa, che non lo può spiegare”.
È stato poi l’insigne poeta ottocentesco Giacomo Leopardi a definire la malinconia uno stato della mente non necessariamente negativo, a meno che non la si lasciasse incancrenire o divenire costante motivo di isolamento dal mondo esterno.
Egli, nella lettera che scrisse a Pietro Giordani nell’aprile del 1817, aveva approfondito proprio la grande differenza tra una malinconia dolce e delicata, la quale può portare l’uomo a profonde riflessioni e pensieri creativi divenendo così linfa vitale per l’arte in ogni sua forma, e, invece, una malinconia oscura, opprimente e lacerante:
“So ben io qual è, e l’ho provata, ma ora non la provo più, quella dolce malinconia che partorisce le belle cose, più dolce dell’allegria, la quale, se m’è permesso di dir così, è come il crepuscolo, dove questa è notte fittissima e orribile, è veleno, come Ella dice, che distrugge le forze del corpo e dello spirito”.
La letteratura in Leopardi sembra allora essere prodotto della malinconia.
Concezione contrapposta totalmente alla visione della scrittura di Giovanni Boccaccio il quale, nella parte conclusiva del “Decameron”, ha sottolineato quanto questa potesse divenire un modo per “scacciare la malinconia”.
Oltre a ciò, la condizione dello spirito di Leopardi può essere percepita in maniera ancor più incisiva e intensa nella poesia “L’infinito” e, soprattutto, nell’ultimo verso: “e il naufragar m’è dolce in questo mare”, nel quale il poeta ha rievocato la meraviglia e la dolcezza dell’abbandonarsi all’immensità e complessità della mente umana, dello spazio e del tempo.
Se la malinconia in Hugo sembrava essere assimilabile quasi alla gioia, e in Leopardi appariva come di due nature differenti, invece, con il poeta ottocentesco Charles Baudelaire,
ha assunto un significato negativo, divenendo sinonimo di noia e depressione.
Baudelaire ha utilizzato, riferendosi a tale ombra malinconica e tediosa, il termine inglese “spleen”, ovvero “milza”, rifacendosi dunque ad antiche credenze che identificavano quest’organo come la causa della depressione, quindi di profonda malinconia, tristezza e angoscia esistenziale, le quali attanagliano l’uomo e lo conducono a un senso di disperazione alimentato ancor di più dall’incapacità di spiegarsi le cause di tale male.
Baudelaire ha reso questo sentimento oscuro il perno della propria produzione letteraria, giungendo a descriverlo in ben quattro liriche intitolate “Spleen”, tra le quali una in particolare emerge per la violenza delle immagini evocate:
“Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve schiaccia l’anima che geme nel suo tedio infinito, e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte
fa del giorno una tristezza più nera della notte;
quando la terra si muta in un’umida segreta dove, timido pipistrello, la Speranza
sbatte le ali contro i muri e batte con la testa nel soffitto marcito;
quando le strisce immense della pioggia
d’una vasta prigione sembrano le inferriate e muto, ripugnante un popolo di ragni
dentro i nostri cervelli dispone le sue reti,
furiose a un tratto esplodono campane
e un urlo tremendo lanciano verso il cielo,
così simile al gemere ostinato
d’anime senza pace né dimora.
Senza tamburi, senza musica, dei lunghi funerali sfilano lentamente nel mio cuore: Speranza piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra,
pianta sul mio cranio riverso la sua bandiera nera”.
Una sfumatura di malinconia altrettanto oscura traspare dall’opera “L’inchiostro della malinconia” di Jean Starobinski, critico letterario e psichiatra contemporaneo.
All’interno di tale libro assai raffinato e armonioso, la malinconia è stata dipinta dall’autore “nera come l’Inferno e come l’inchiostro”, poiché capace di tingere l’anima di oscurità paralizzando le emozioni e la parola.
“Il malinconico”, ha scritto il filologo Corrado Bologna in un articolo pubblicato sul giornale “il manifesto”, “pensa ossessivamente alla vita in termini di «se avessi» o «se non avessi» fatto questo o quello, fissandosi senza salvezza «su un passato che non può più modificare», come annotò acutamente il grande psichiatra Ludwig Binswanger, ricordato da Starobinski”.
Starobinski ha inoltre richiamato nell’opera la metafora del “pozzo profondo della malinconia”, che egli ha recuperato da Charles d’Orléans, poeta e compositore francese del Quattrocento, con il quale la malinconia venne, forse per la prima volta nella letteratura occidentale, accostata all’immagine di profondità.
“L’inchiostro della malinconia” si distingue per l’esemplare erudizione conferita dalle numerosissime analisi testuali, svolte dapprima da Pessoa e poi ricordate da Starobinski, su letterati e filosofi quali Robert Burton, Cervantes, Hoffmann, Kierkegaard, Madame de Staël, Roger Caillois, Pierre Jean Jouve e Baudelaire.
Emerge infine, da “L’inchiostro della malinconia”, il valore salvifico della letteratura, della poesia e, più genericamente, dell’arte: è proprio l’inchiostro della penna a divenire unico antidoto efficace in grado di purificare lo spirito da un inchiostro del tutto diverso, quello densissimo di una malinconia aggressiva e tagliente.
Jean Starobinski, inoltre, apprezzava molto il poeta e scrittore del XVI secolo Torquato Tasso e il filosofo del XVIII secolo Jean-Jacques Rousseau. Tali due figure erano accomunate proprio da un’assidua malinconia, divenendo specchi della vita di Starobinski, il quale, studiando approfonditamente le loro vite, diede una definizione al contempo umanistica e scientifica di tale sentimento complesso e articolato.
Certamente, nonostante la complessità delle sfumature della malinconia, si può affermare con certezza che il nucleo costitutivo di questa emozione sia la consapevolezza di un tempo ormai lontano che conserva la propria interezza, come un quadretto perfettamente intatto ma impolverato, nei meandri di uno spirito sofferente.
La tematica del tempo attraverso una nostalgia indefinita e celata, viene mostrata, con grande attenzione ad ogni dettaglio, nel romanzo moderno “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati, scrittore e giornalista del secolo scorso.
Il romanzo è costellato da pagine e pagine di “promemoria” celati negli avvenimenti e volti a ricordare, sia al protagonista che al lettore, che, il tempo, anche quando sembra scorrere con una lentezza disarmante, in realtà finisce per inghiottire ogni misera vita umana con angosciante velocità.
Tale promemoria, che risulta essere vano almeno per il protagonista Giovanni Drogo, rende pregno di malinconia indefinita l’intero romanzo, il quale diviene emblema dell’impossibilità per la ragione umana di controllare gli eventi della propria vita e avere interamente consapevolezza dello scorrere temporale.
C’è qualcosa di meravigliosamente profondo nei motivi che spingono un uomo ad abbandonarsi alla bellezza unica dell’arte in ogni sua sfumatura e a tentare di dare una forma al groviglio irrisolvibile e tormentato d’una essenza sempre in parte incomprensibile e sconosciuta.
La malinconia, quel pozzo abissale e spaventoso di cui ha parlato Charles d’Orléans, e, al contempo, quella venatura intensa di delicato amore per le più essenziali cose della vita, diviene un ricorrente motivo letterario di tale profondità e intimità da abbracciare anche altre forme d’arte, come la musica e la pittura, le quali senz’altro fanno pensare rispettivamente alla dolce malinconia mozartiana e a quella rappresentata da Edvard Munch alla fine dell’Ottocento.
Nonostante i grandi passi avanti delle neuroscienze in merito agli input cerebrali che causano nell’essere umano il sentimento di malinconia e nostalgia, ci saranno sempre, nella mente dell’uomo, delle venature incomprensibili e segrete, immensamente affascinanti.
In un mondo in cui la specie umana porta avanti con illusione la pretesa di dare una spiegazione anche alla forma più elevata di astrattismo, la malinconia e la nostalgia divengono emblema dello spesso dimenticato fascino dell’inconoscibile, il quale prende vita, ricolmo di sé, nelle più incantevoli forme d’arte.
Traendo ispirazione da Starobinski, si potrebbe pensare, in conclusione, alla malinconia (ma anche alla letteratura) come a un farmaco omeopatico, che, cioè, cura il sintomo esasperandolo; cura il male con il male.